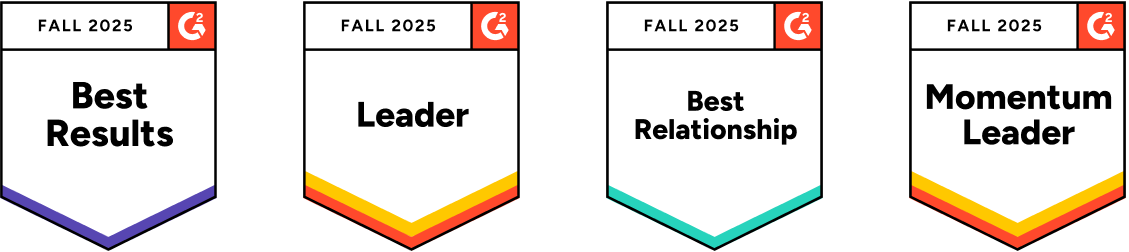Come trasformare il P&L in uno strumento strategico

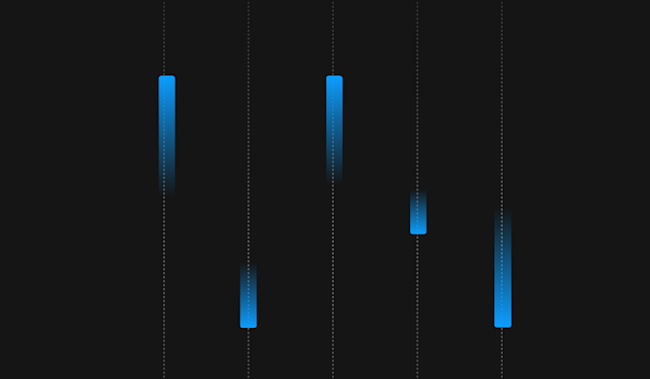
Mentre in Italia la normativa impone il conto economico come documento di riferimento per l'analisi della redditività aziendale, tra le grandi imprese si diffonde sempre più l’uso del P&L, una versione del conto economico redatta secondo i principi internazionali, e che pone l’accento su indicatori chiave come l’EBITDA.
Perché proprio il P&L? Perché, soprattutto per le aziende che vogliono attrarre investitori, il conto economico “internazionale” garantisce uniformità e confrontabilità dei dati, e agevola perciò la comunicazione con i soggetti esterni all'azienda.
Tuttavia, il P&L rischia spesso di essere troppo limitante per valutare le performance reali di un’impresa. Un’analisi iperfocalizzata sugli aspetti economici, che trascura la dimensione della liquidità, può infatti esporre le aziende a rischi finanziari concreti, a partire da quelli legati alla cassa.
In questo articolo esploreremo cos’è il P&L, in cosa differisce dal conto economico italiano e come adottare un approccio più integrato, ispirato a una cash culture che mette la liquidità al centro delle scelte strategiche.
P&L, o profit and loss. Di cosa parliamo?
Profit and loss . Profitto e perdita. Due parole che fanno parte del vocabolario essenziale di chiunque gestisca un'azienda. Perché, in fin dei conti, il successo di qualsiasi impresa non si basa che su questo scontro: il rischio di perdite contro le probabilità di profitto. Con P&L, però, si intende – generalmente – qualcosa di molto più specifico: e cioè un documento contabile, che in italiano è più comunemente detto conto economico , e che – di fatto – è la rendicontazione di tutti i costi aziendali e di tutti i ricavi, dal cui confronto emerge o un eventuale perdita o il profitto dell'azienda.
Perché P&L, e non conto economico?
L'espressione P&L, spesso anche P&L statement, è una traduzione – più o meno diretta – di conto economico. In sostanza, conto economico e P&L rappresentano la stessa funzione, pur con differenze strutturali. Ma perché parliamo proprio di P&L, e non di conto economico? Perché nel contesto globalizzato che è tipico del private financing (e non) è bene che i parametri siano uniformi. Nello specifico, il P&L segue il framework IAS/IFRS, cioè il principio contabile internazionale che a volte differisce dall'OIC, il principio contabile nazionale.
Una delle differenze principali riguarda lo schema del conto economico. In Italia, il conto economico adotta una classificazione dei costi per natura (es. costi delle materie prime, del personale) e segue uno schema basato su valore e costo della produzione. Al contrario, i principi contabili internazionali preferiscono una classificazione per destinazione (es. costi amministrativi, costi per ricerca e sviluppo) e si basano su un modello fondato su ricavi e costi del venduto.
L'uso del P&L è quindi più di una scelta linguistica. Il P&L statement, come espressione linguistica, permette una precisa uniformità di calcolo e linguaggio che agevola la comunicazione con i partner esteri, stakeholder e investitori.
Perché il P&L statement è così importante?
Non solo il P&L statement è importante; lo è anche in modo diverso e per diversi attori in gioco. Abbiamo già chiarito che si tratta di un documento contabile – e vedremo in seguito, nel dettaglio di cosa si compone. Perciò, come ogni documento contabile, serve:
- •
ai reparti finanziari, per valutare lo stato di salute dell'impresa ma anche per sviluppare una migliore strategia di ottimizzazione delle risorse (es. riducendo gli sprechi o la sovrapproduzione, e così via)
- •
ai soggetti esterni, come investitori e stakeholder, che hanno bisogno di misurare le performance di un'azienda, e quindi di calcolarne la redditività tramite indici, prima di lanciarsi in un investimento potenzialmente rischioso
C'è poi un altro fattore da tenere in considerazione. E cioè che, in Italia, il P&L (o, meglio, il conto economico) resta un documento contabile obbligatorio, secondo la legge, per lo meno per una buona fetta delle imprese italiane tra cui:
- •
le società di capitali (SpA, Srl)
- •
le società di persone (Sas, Snc)
- •
le società quotate in borsa
In questi casi, il conto economico va incluso tra i documenti del bilancio d'esercizio, insieme allo stato patrimoniale, al rendiconto finanziario e – se serve – alla nota integrativa. Tutti documenti contabili che offrono una visione specifica dello stato di salute aziendale, seppure su fronti diversi: mentre, per esempio, lo stato patrimoniale (che gli anglofoni chiamano balance sheet) può dirci molto sulla solvibilità di un'azienda, quindi sul rapporto tra patrimonio, asset e debiti, il P&L si concentra sulla sua redditività, cioè sulla capacità di generare profitto dalla sua gestione operativa.
Di quali elementi si compone un P&L statement?
Il documento P&L segue uno schema ben preciso (che vedremo meglio nel paragrafo successivo), dentro cui sono inclusi:
- •
ricavi, o revenues
- •
costo del venduto, o COGS (cost of goods sold)
- •
profitto lordo, o gross profit
- •
spese operative, o OPEX (operating expenses)
- •
EBIT (Earnings before Interest and Tax)
- •
utile netto, o net income
Come potrai notare, le voci del P&L sono diverse dalle voci del conto economico. Il conto economico, infatti, è composto da:
- •
valore di produzione
- •
costi di produzione
- •
proventi e oneri finanziari
- •
rettifiche
- •
imposte sul reddito d'esercizio
- •
utile netto
Possiamo vedere meglio la differenza tra le voci in questo schema.
P&L Statement | Conto economico |
|---|---|
Revenues | Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazione per lavori interni 5) altri ricavi e proventi |
Costo del venduto | Costi della produzione 6) per materie prime, etc. 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, etc. 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione |
Profitto lordo | Differenza tra valore di produzione e costi di produzione |
Spese amministrative | Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, 16) altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 17-bis) utili e perdite su cambi |
Spese operative | Rettifiche di valore di attività e passività finanziario 18) rivalutazioni 19) svalutazioni |
Utile operativo | Risultato prima delle imposte 20) imposte sul reddito dell'esercizio, etc. 21) utile o perdita d'esercizio |
Altri redditi | – |
EBITDA | – |
D&A | – |
EBIT | – |
Reddito netto | – |
Lo schema ci rende immediata la differenza di framework tra l'elaborazione del conto economico italiano e il P&L statement internazionale. Tuttavia, il risultato finale – in entrambi i casi – è lo stesso.
Come i reparti finanziari utilizzano il P&L
Scrivevamo prima: il P&L permette di analizzare da vicino la redditività aziendale. Ed è vero. Un documento che mette nero su bianco quali sono i costi, e quali i ricavi in relazione ai costi, ci dice già moltissimo sulla performance finanziaria complessiva dell'azienda. Del resto, il P&L consente di calcolare l'EBITDA che, insieme al MOL (margine operativo lordo), rappresenta uno degli indici di redditività più utilizzati per valutare la gestione operativa aziendale.
Il vantaggio sta proprio nell'analisi per costi e ricavi, il cui rapporto – come già dicevamo – è fondamentale per la solidità e solvibilità di un'impresa. Il P&L dice subito, per esempio, da dove partire per ampliare i margini di profitto e se ci sono aree di miglioramento possibili nella gestione dei costi.
Supponiamo che la tua azienda abbia margini di profitto bassi: osservando il P&L statement, potrebbe accorgersi che l'EBIT – cioè il reddito operativo – viene eccessivamente eroso dagli interessi passivi, producendo un reddito netto insoddisfacente. A quel punto, il reparto finanziario avrebbe informazioni a sufficienza per puntare a una gestione del debito finanziario più efficiente, e quindi a un contenimento degli oneri finanziari. Oppure potrebbe emergere un problema nella gestione delle spese, da ottimizzare – a quel punto – pur salvaguardando l'efficienza operativa.
In questo senso, il P&L statement rappresenta un ottimo punto di partenza per la pianificazione finanziaria. L'analisi di profit and loss torna utile, infatti, nelle fasi di forecasting e budgeting.
- •
Il forecasting, cioè l'attività di previsione, ha bisogno di dati storici perché sia efficace. All'interno del P&L sono incluse tutte le voci di costo e di ricavo che l'azienda ha registrato in un determinato periodo. Tieni conto che il P&L può essere redatto sia per l'anno fiscale che su base mensile o trimestrale. Più approfondita è l'analisi, maggiori saranno i dati a disposizione per elaborare una previsione accurata.
- •
Il budgeting, invece, può contare sul P&L per avere una base realistica da cui partire. Il documento può fungere da benchmark interno, utile nel controllo di gestione, e dare un'indicazione rispetto agli obiettivi da fissare nell'immediato futuro.
Rispetto al budget aziendale, bisogna anche dire che la prassi prevede – idealmente – l'elaborazione di due diversi P&L statement: uno P&L consuntivo, che mostra i dati passati, e un budget P&L, che in Italia è associabile al budget economico – sebbene quest'ultimo venga in genere costruito secondo una riclassificazione a valore aggiunto, piuttosto che a costo del venduto.
Cash culture vs analisi per profit and loss
In questa fase, è bene dedicare un approfondimento al P&L in contrapposizione con la cash culture, cioè quel framework aziendale che dà priorità ai dati finanziari (entrate, uscite, flusso di cassa) rispetto ai costi e ai ricavi. Per farlo, dobbiamo prima partire da un dato:
- •
in Italia, a livello contabile, si applica di default il principio di competenza che tiene conto, nella redazione dei documenti contabili, precisamente dei costi e dei ricavi, a prescindere dalla manifestazione finanziaria di ciascuno di essi. In altre parole, secondo il principio di competenza, un costo viene registrato anche quando non si è manifestato ancora in una spesa, ovvero in un'uscita di cassa.
Tutte le aziende che adottano un regime di contabilità ordinaria applicano il principio di competenza.
Contrapposto al principio di competenza, troviamo invece il principio di cassa, applicato dalle imprese in regime di contabilità semplificata, ma anche da lavoratori autonomi, organizzazioni non profit, etc. Il principio di cassa tiene conto dei movimenti finanziari, quindi delle spese invece che dei costi, delle entrate invece che dei ricavi.
È un principio che fa la differenza, perché pone il focus sul cash flow, cioè sulla liquidità aziendale. Che è poi di fatto, più del reddito netto, la vera linfa vitale di ogni impresa. Il principio di cassa opera uno shift di paradigma, che porta a quella che in Agicap viene definita una "cash culture" o, appunto, cultura della liquidità.
Tralasciando gli obblighi normativi italiani in ambito contabile, che – ovviamente – non possono essere aggirati, è chiaro però che anche le grandi aziende possano beneficiare di una analisi interna basata sul principio di cassa, e quindi sul cash flow. Per fare un esempio, la pianificazione finanziaria basata sul P&L, e quindi su indicatori come l'EBITDA, tralascia tutta una serie di aspetti che invece sono fondamentali per la solidità di un'impresa – come i livelli di liquidità, o lo stesso rischio di liquidità, che invece ha bisogno di indicatori puramente finanziari, es. il DSO (tempo medio di incasso), il fabbisogno di capitale circolante, e così via.
Il P&L, dunque, pur ricoprendo un ruolo importante per i reparti finanziari, presenta però molti limiti. Limiti che una cash culture è invece in grado di superare.
Le sfide comuni nell'ambito del P&L management
I limiti del metodo Profit and Loss, illustrati nel paragrafo precedente, si aggravano quando la gestione del P&L avviene in un contesto aziendale ancora troppo “tradizionale”, per non dire anacronistico. Un contesto, per esempio, che si affida ancora a un monitoraggio manuale dei dati: un sistema frammentario e lacunoso, che funziona ancor meno in realtà complesse o multi-entità.
Nel contesto del P&L management, la gestione manuale dei dati compromette l’efficienza dei team finanziari, costretti a gestire:
- •
dati disallineati, poco uniformi e obsoleti
- •
un'attività di riconciliazione fin troppo complessa
- •
spreco di tempo e risorse in task ripetitive
- •
un altissimo margine di errore nel tracking dei dati
- •
difficoltà durante il controllo di gestione
L'impatto sui risultati dell'azienda può essere enorme, specie se – per colpa di un sistema fallace – i team finanziari perdono, o addirittura non si accorgono, di eventuali opportunità di miglioramento.
Un esempio lampante riguarda i gruppi societari, che producono P&L statement per l'intero gruppo, e non solo per le singole entità. Un P&L efficace è quello che include dati consolidati e attendibili, ma soprattutto ancora validi e non di certo obsoleti. Per riuscirci, i reparti finanziari hanno bisogno di avere accesso ai dati di tutte le entità in tempo reale, o comunque con uno scarto di tempo minimo.
Immaginiamo allora un gruppo societario che ancora ricorre a strumenti tradizionali, seppur digitali, come i fogli Excel. Il consolidamento dovrebbe tenere conto di una moltitudine di fogli Excel condivisi tra le singole entità del gruppo, spesso redatti secondo parametri e logiche diverse. In casi come questi, il rischio di incongruenze nei dati è altissimo. Il che inficia, inevitabilmente, il lavoro dei reparti finanziari nonché tutta l'operazione di elaborazione del P&L, che a quel punto perderebbe efficacia. Un profit and loss prodotto in questi termini rappresenta, di fatto, uno spreco di tempo e di risorse per l'azienda.
L'uso di software come Agicap per la gestione del P&L
La digitalizzazione ha cambiato i metodi di lavoro dei reparti finanziari, anche nell'ambito della gestione del P&L. I software di gestione finanziaria, del resto, risolvono uno dei problemi più grandi per chi si occupa di Profit and Loss, cioè la scarsa accuratezza dei dati, e ci riescono grazie a un'automatizzazione del monitoraggio inimmaginabile con strumenti come Excel.
In particolare, un software come Agicap, che pone il focus sulla tesoreria aziendale, riesce a superare il gap tra l’analisi economica e quella finanziaria dell’impresa. In altre parole, agevola i reparti finanziari nell'implementazione della cash culture, come la definivamo prima: un approccio che pone maggiore attenzione sulla liquidità e i suoi indicatori, tra cui il flusso di cassa, e che offre un punto di vista ancora più strategico sulla gestione di impresa e sulla sua crescita.
Agicap, quindi, integra – nel P&L management – una visione precisa, e in tempo reale, della liquidità, mentre agevola i reparti finanziari nella stesura del P&L statement, a partire da:
- •
una connessione diretta con le banche
- •
la categorizzazione automatica dei movimenti
- •
un consolidamento fluido dei dati in pochi clic
Funzionalità che si rivelano particolarmente preziose per le grandi imprese e i gruppi societari, in particolare se multi-valuta, che devono quotidianamente gestire enormi flussi di dati da fonti eterogenee — come conti correnti diversi o istituti bancari differenti.
Il ruolo di Agicap nella gestione del P&L (in ottica cash)
In che modo Agicap colma il divario tra analisi economica e finanziaria? Cioè, da un approccio che si focalizza su costi e ricavi e uno incentrato sulla liquidità in senso stretto? Per chi lavora con previsioni economiche e analisi finanziarie, Agicap offre una funzione strategica, ovvero P&L to Cash.
Una feature che permette di convertire i forecast economici in piani di cassa, tenendo conto di variabili spesso trascurate nel conto economico, come l’IVA, i tempi di incasso e pagamento, gli investimenti e i finanziamenti. In questo modo, i reparti finanziari hanno la possibilità di tradurre il prospetto di costi e ricavi, quindi la visione economica, in una gestione efficace della liquidità.
Il setup iniziale è, tra l'altro, molto semplice e si esegue in pochi passaggi. Basta:
- •
importare sul software un P&L previsionale
- •
allineare le voci del P&L alle categorie smart di Agicap
- •
impostare le scadenze di pagamento o eventuali ritardi
- •
aggiungere investimenti e finanziamenti
A quel punto i dati verranno integrati al piano di cassa elaborato dal software stesso. Il risultato? Una visione chiara, realistica e sempre aggiornata della liquidità aziendale, perfettamente integrata con gli obiettivi economici.
Vuoi vedere come Agicap può semplificare e automatizzare la gestione del tuo P&L, integrando analisi economica e finanziaria?
Prenota ora una demo gratuita e personalizzata con un nostro esperto e scopri tutte le funzionalità in azione!
Altri consigli su come gestire il Profit and Loss
Trasformare il P&L in uno strumento più dinamico, operativo e integrato con i dati di cassa è, oggi, una prerogativa per le aziende. Soprattutto in un contesto – come il nostro – che richiede una rapidità decisionale senza precedenti. Il P&L oggi può – e deve – evolversi, virando verso la cash culture di cui abbiamo parlato finora. Perché soltanto così può fungere da leva strategica per affrontare il futuro con consapevolezza.
Ecco allora altri consigli extra per gestire al meglio il P&L.
1. Allineare le voci di ricavo e costo agli obiettivi aziendali
Una prima mossa strategica è strutturare le categorie di ricavo e costo in modo coerente con i KPI aziendali. Troppo spesso, le voci del P&L riflettono una logica contabile che dice poco sull’efficacia delle singole business unit o sull’andamento delle performance operative.
Riorganizzare il conto economico attorno agli indicatori chiave del business — come margine operativo lordo per linea di prodotto, costi variabili per canale, ricavi ricorrenti vs una tantum — rende l’analisi più leggibile e azionabile.
2. Superare il budget annuale (e adottare i rolling forecast)
Nel mondo reale, le condizioni cambiano più velocemente dei bilanci. Ecco perché molte aziende stanno passando da una logica di budget annuale statico a una più fluida, basata sul rolling forecast, o – in altre parole – su previsioni continue, aggiornate mensilmente o trimestralmente, che permettono di correggere la rotta in corsa.
3. Connettere il P&L alla gestione della liquidità
Un altro passo fondamentale è integrare l’analisi economica con quella finanziaria. Il P&L non mostra quando entrano o escono i soldi, ma solo quando vengono contabilizzati i ricavi e i costi. Strumenti come Agicap si muovono precisamente in questa direzione, e colmano il divario tra conto economico e piano di cassa integrando elementi come:
- •
tempi di pagamento e incasso,
- •
IVA da versare o da incassare,
- •
investimenti e finanziamenti.
È solo così che il P&L diventa realmente utile per il controllo della liquidità aziendale, non soltanto per l’analisi di margini e risultati – che offrono una prospettiva interessante, ma pur sempre limitata.
4. Automatizzare il consolidamento tra unità o sedi
Quando si lavora in un’organizzazione complessa, con più sedi o business unit, la raccolta dei dati e il consolidamento dei P&L può trasformarsi in un’attività lunga, frammentaria e soggetta a errori. Per questo è fondamentale automatizzare questo processo.
Per fare un esempio, l'automatizzazione tramite software permette di integrare più fonti dati in un unico ambiente di lavoro, il che si traduce in un guadagno di tempo e in una riduzione drastica degli errori. Senza dimenticare che un software garantisce un certo livello di uniformità nelle analisi.
In sintesi, una visione centralizzata (e confrontabile) dei dati rappresenta un enorme beneficio: sia in fase decisionale che per comunicare meglio con investitori e stakeholder.
5. Introdurre KPI operativi ispirati alla cash culture
L'ultimo consiglio riguarda proprio i KPI. Che nella cash culture cambiano, o meglio: vengono sostituiti da – o integrati con – key performance indicator legati alla liquidità aziendale. In quest'ottica, i reparti finanziari dovrebbero porre maggiore attenzione a:
- •
DSO, o tempo medio di incasso
- •
DPO, o tempo medio di pagamento
- •
DIO, o tempo medio di giacenza in magazzino
- •
fabbisogno di capitale circolante in azienda
KPI di questo tipo aiutano a leggere il conto economico in chiave dinamica, e a monitorare l’impatto reale delle decisioni sull’equilibrio finanziario. È così che si trasforma il P&L in una leva davvero strategica.
FAQ, o domande più frequenti
Cosa si intende per P&L?
P&L è l’acronimo di Profit and Loss statement. Si tratta di un documento che riassume ricavi, costi e profitti (o perdite) di un’azienda in un determinato periodo. Serve a valutare la redditività dell’impresa, misurando quanto guadagna o perde in base alla sua attività operativa. È associabile al conto economico italiano, anche se presenta una struttura diversa: il P&L, infatti, viene redatto secondo i principi contabili internazionali.
Cosa significa analisi P&L?
Analizzare un P&L significa esaminare in dettaglio le voci di ricavo e costo per comprendere la redditività dell’azienda. L’analisi P&L aiuta a identificare trend, inefficienze, aree di profitto e criticità operative. È uno strumento fondamentale per valutare l’andamento economico, prendere decisioni strategiche e pianificare il futuro in modo consapevole. Ma anche per comunicare con successo con banche, investitori e stakeholder.
Come si calcola il P&L?
Il calcolo del P&L – secondo i principi contabili internazionali – parte dalla somma dei ricavi generati nel periodo, da cui viene sottratto il costo del venduto, le spese amministrative, le spese operative, ammortamenti e svalutazioni, interessi e tasse. Il risultato è l'utile (o la perdita) netta. Il calcolo, comunque, può seguire schemi diversi a seconda del principio contabile adottato.
Riferimenti
Antonella Portalupi, Principi contabili OIC/IFRS: differenze e analogie, Ipsoa, 2022
Ragioneria.com, Modello a “valore e costo della produzione”
Ragioneria.com, Modello a “ricavi e costo del venduto”